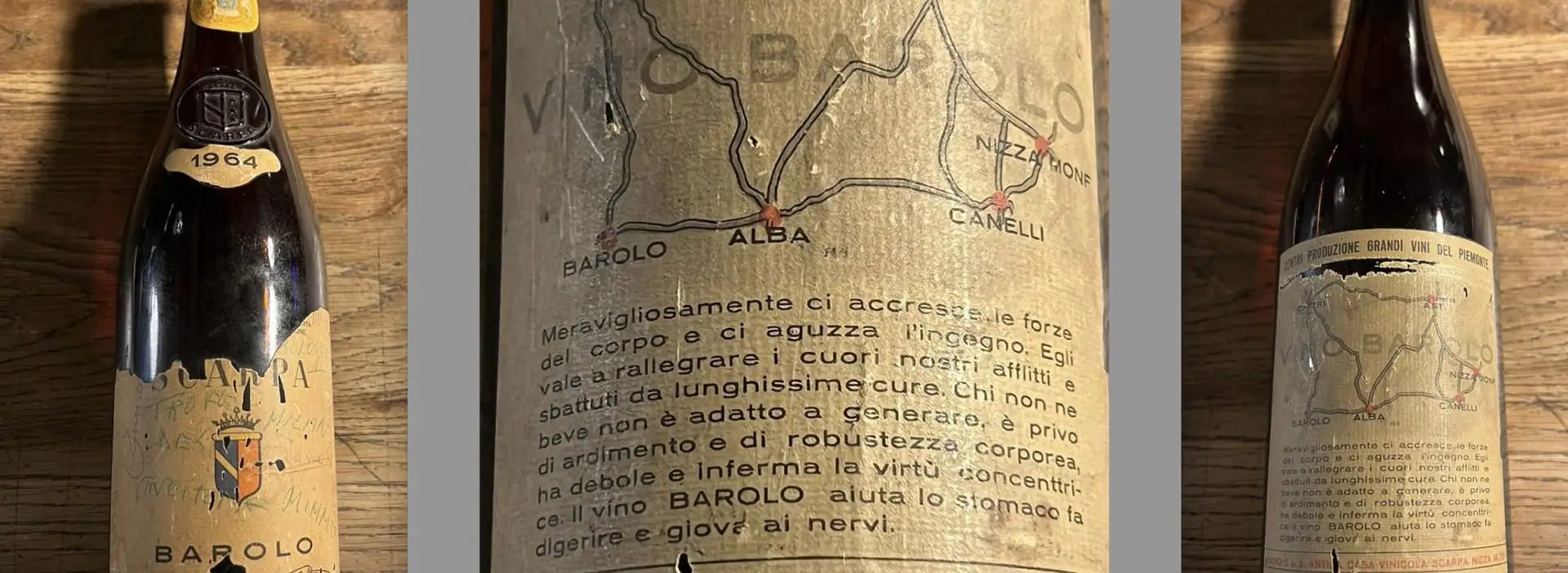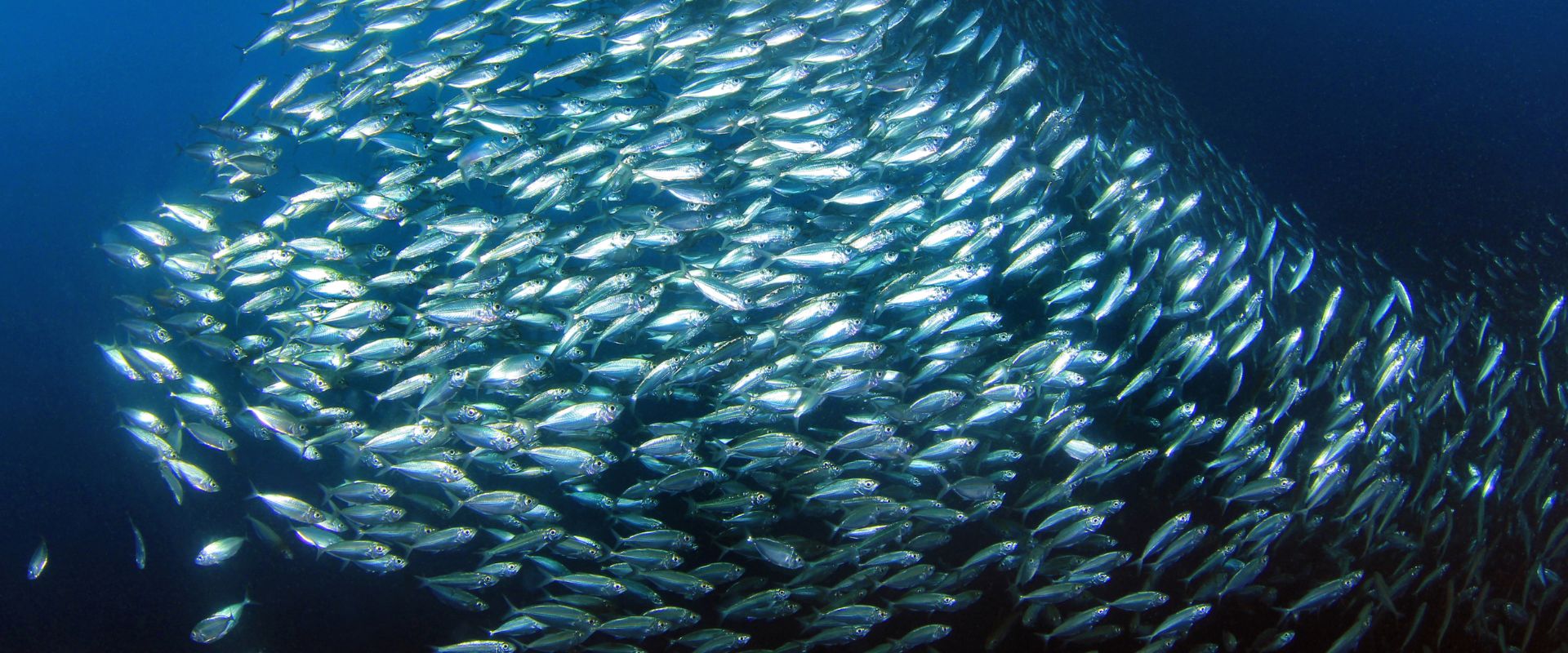- Le storie di Mimmo
Era mia madre
Tempo di lettura: 6 minuti
Il lavoro al ristorante, sette giorni su sette. E sette figli da crescere. Sette,come le camicie che sudava quotidianamente per arrivare a sera, un modo di dire forse un po’ antiquato ma che ben si adatta all’esistenza che ha condotto mia madre.
Tutte le faccende di casa erano sulle sue spalle. E non vi erano collaboratrici domestiche che alleggerissero il peso di incombenze che non finivano mai. Poi c’era il nostro locale, dove mia madre, in cucina, prendeva sovente possesso di fuochi e padelle per preparare alcuni piatti di cui era l’unica depositaria di tempi, procedimenti e ingredienti segreti. Come la parmigiana di melanzane.
Sessant’anni fa, rischiando le invettive se non addirittura la scomunica dell’intero parentado, decise di non friggere più le melanzane. Secondo lei era possibile ottenere una pietanza altrettanto buona, e molto più digeribile, senza utilizzare tutto quell’olio. E così fece.
È straordinario pensare a una donna calabrese nata all’inizio del secolo scorso che, negli anni Cinquanta, interpreta a modo suo una ricetta tradizionale per renderla più adatta ai tempi che cambiano.
Quella sua vita densa di impegni e occupazioni quotidiane, le lasciava davvero poco, pochissimo tempo da dedicare a se stessa. E nessuna concessione al voluttuario. Tranne una volta.
Principesse ed eredi al trono
Ricordo quella sera d’inverno – con pochi avventori seduti ai nostri tavoli – in cui la sorpresi a sfogliare una rivista, quasi di nascosto, sotto il tiretto della cassa.
Non si trattava della sua amata Famiglia Cristiana. L’avevo intuito da come voltava le pagine, quasi con timore reverenziale. Incuriosito, mi avvicinai di soppiatto. Accortasi della mia presenza silenziosa e incombente, si ritrasse imbarazzata mostrando sul viso la sua consueta espressione, per nulla incline al sorriso gratuito.
Feci a tempo a sbirciare. Si trattava di un rotocalco, di quelli che indagano sulle vicende delle celebrità. Star del cinema e dello sport, imprenditori di successo e politici rampanti, principesse ed eredi al trono. Gianni Agnelli e Aristotele Onassis, Mina e Sofia Loren, con un occhio di riguardo per le vicissitudini di Buckingham Palace e del Principato di Monaco.
Non lo avrebbe mai ammesso, ma mia mamma era attratta dalle saghe incantate e turbolente delle famiglie reali. Più di una volta, negli anni a venire, in compagnia delle mie sorelle, la sentii commentare con autentico trasporto episodi e accadimenti che riguardavano Grace Kelly, tanto bella quanto sfortunata, o le sue figlie perennemente infelici in amore. Per non parlare delle disavventure di Diana Spencer e dell’insensibile Carlo, futuro re d’Inghilterra.
Ammirava la naturalezza con cui i reali si destreggiavano in ogni circostanza, che fosse una festa in maschera o un funerale di stato. E adorava i loro vestiti. Le ricordavano quelli che lei cuciva da ragazza, in una nota sartoria di Reggio Calabria, per le attrici che avrebbero recitato sul palco del Teatro Francesco Cilea, il più bello e il più grande di tutta la regione, con la sua architettura tesa a riproporre i fasti della Magna Grecia.
Io, tutto cinema e pallone, non capivo proprio come mia madre potesse essere affascinata da storie tanto insulse e melense, così distanti dal mio mondo e dal suo. Una realtà parallela che sembrava appartenere a un altro universo.
Quella sera fui preso da una sorta di turbamento stralunato per aver colto un lato del carattere di mia mamma che non immaginavo esistesse. Fantasticava su vite lontane e impossibili, vinta da un desiderio insopprimibile di leggerezza, un qualcosa che nella sua vita non aveva mai avuto modo di conoscere.
Il bottone di una camicia
Da ragazzo, ero spesso preda della mia irrequietezza ed esuberanza. Le discussioni con i miei fratelli e con papà non mi infastidivano affatto, anzi mi divertivano, ma con mia madre non c’era gusto. Restava impassibile, non perdeva mai la pazienza e al massimo scuoteva la testa, mantenendosi ferma sulle sue posizioni, senza alcun cedimento o possibilità di trattativa.
Una volta, in cui ero davvero arrabbiato con lei – anche se non ricordo assolutamente il motivo, perciò non doveva essere poi così importante – uscii di casa sbattendo rumorosamente la porta. In preda alla collera, decisi di fare appositamente tardi, augurandomi che lei si preoccupasse per me, disperandosi e chiedendosi dove fossi andato.
Quando rientrai, verso la mezzanotte, la vidi seduta in cucina intenta a riattaccare un bottone a una mia camicia. Restai fermo e immobile nella penombra della sala, senza farmi vedere. Osservai le sue mani esperte destreggiarsi agilmente con ago e filo. Gesti rapidi, precisi ed essenziali. Fui travolto da un sentimento caldo e avvolgente. Era amore filiale e mi sentii in colpa per l’inutile sceneggiata del pomeriggio.
Nel nostro cervello esiste un’area chiamata amigdala che riveste un ruolo fondamentale nella gestione delle emozioni, così come nello sviluppo della memoria visiva e nell’elaborazione degli stimoli provenienti dagli organi di senso. Questa piccola struttura cerebrale a forma di mandorla analizza ogni esperienza, considerando le differenti situazioni.
Pare che l’amigdala sia più sviluppata nelle donne. Di sicuro lo era in mia madre. Per questo non aveva così bisogno di parlare. Ma di cantare sì. Ogni tanto, mentre stirava o rassettava la cucina, la sentivo intonare qualche canzone che aveva sentito alla radio.

Con gli occhiali da sole
Chissà perché, i ricordi più vivi che ho di mia madre sono legati a momenti di vita quotidiana apparentemente marginali. La sua voce sottile, ma perfettamente intonata, che accenna a Morandi o a Celentano. La sua partecipazione emotiva al dolore provato da Carolina di Monaco, rimasta vedova a trent’anni, o al dispiacere sincero per la tragica morte di Lady D.
Di mia madre posseggo un sola fotografia in cui indossa occhiali da sole. È a Roma ed è in posa accanto a papà. Un viaggio nella città eterna per una necessità assai pratica: mia sorella doveva essere visitata da uno specialista. Nulla di grave, ma quella non era una scampagnata per visitare San Pietro e pranzare – con la parmigiana rigorosamente portata da casa – su una panchina, all’ombra, nel parco di Villa Pamphili. Eppure, mamma era felice e sorridente.
Lei e mio padre, in quello scatto, hanno quell’espressione inconfondibile che assumono gli italiani in gita all’estero. Una foto ricordo, a colori, di loro due dinanzi al colonnato della basilica di Santa Maria in Trastevere, ma potrebbe essere un’altra chiesa, da recapitare ai parenti lontani, magari al di là dell’oceano.
Se una cosa è da fare, si fa.
A ogni modo, mia madre è sempre qui con me. È ovunque. La rivedo nei miei figli, la riconosco nei loro passi. È al mio fianco quando mi faccio la barba o il nodo alla cravatta, quando assaggio il ragù che prepariamo ancora oggi al ristorante rispettando fedelmente le sue indicazioni. Percepisco la sua presenza tutte le volte che metto quei calzini blu in filo di Scozia che mi regalava ogni compleanno. Ne ho almeno una dozzina di paia e li conservo gelosamente in fondo al primo cassetto.
Quel suo modo di sorridere alla tristezza o di piangere di felicità, di essere grata a Dio senza avergli mai chiesto nulla. Quel suo modo di rimanere in silenzio, che era la misura della sua autorevolezza, pacata e conciliante. Quel suo essere “al servizio” e libera allo stesso tempo.
E poi c’è lei che mi riattacca il bottone a quella camicia. La sua imperturbabile tranquillità figlia del credo che ha condiviso per tutta la vita con papà: “Se una cosa è da fare, si fa”. È quella la vera eredità che mi ha lasciato.