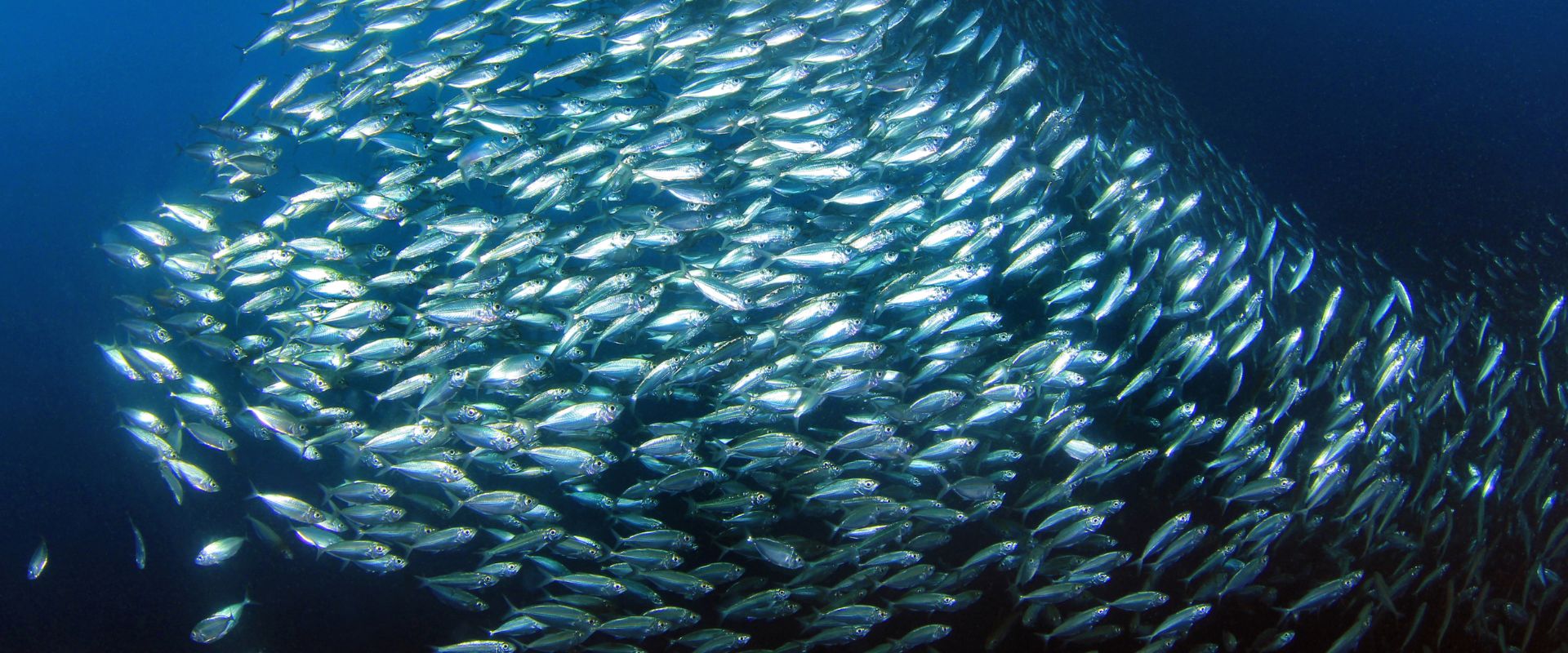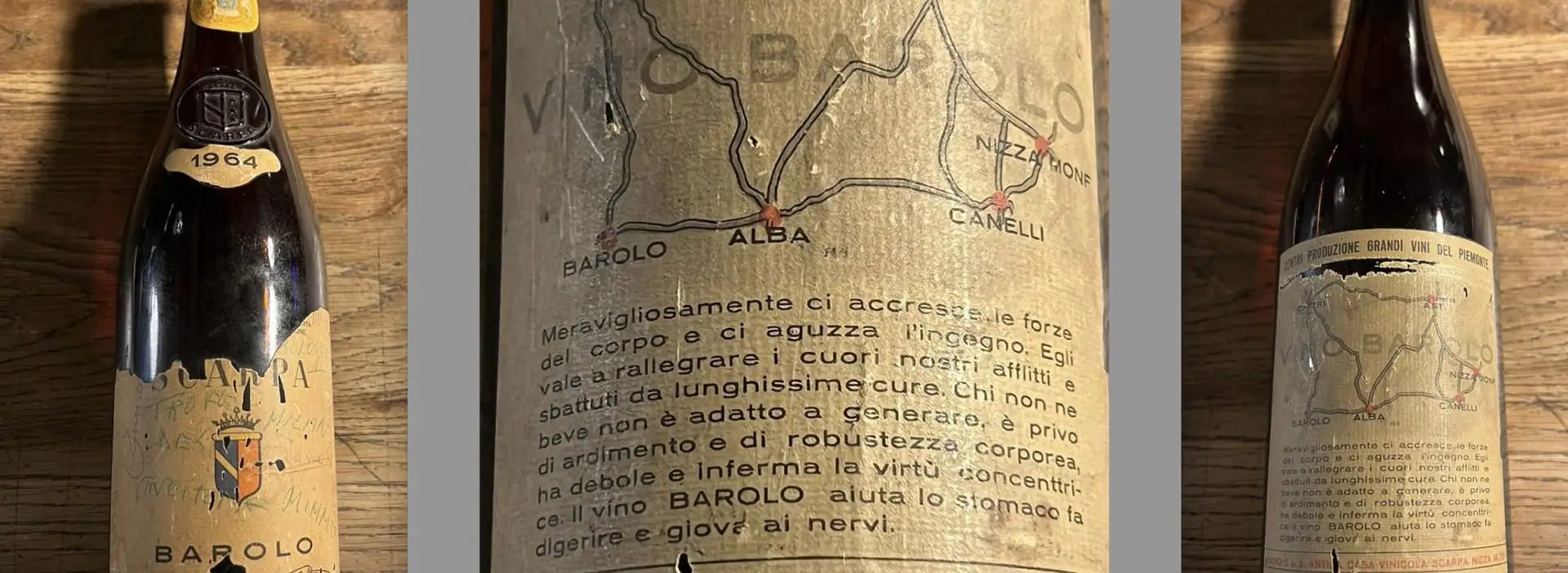- Le storie di Mimmo
Demetrio e il Natale
Tempo di lettura: 6 minuti
Demetrio è un nome di origine greca. Significa sacro a Demetra, la Madre Terra, dea dell’agricoltura, della fertilità e dei raccolti.
Oltre ad essere il nome di battesimo di mio padre, che per tutti fu sempre e solo Mimmo, e del brianzolo Albertini, metronomo infallibile schierato nel cuore del centrocampo del Milan allenato da Fabio Capello, Demetrio era anche il nome di un mio cugino di secondo grado.
L’avevo conosciuto, da bambino, in una delle mie prime vacanze in terra calabra. Più grande di me di una decina d’anni, Demetrio viveva in un cascinale in aperta campagna ma studiava in città per diventare veterinario.
Come tanti ragazzi nati nel Meridione, quando si laureò, si trasferì al Nord alla ricerca di un impiego. Per lui, fu naturale scegliere Bergamo come destinazione. Qui, poteva contare su di noi e su un appoggio temporaneo a casa nostra.
Iniziò a lavorare come tirocinante in una clinica veterinaria ma, trascorse un paio di settimane, Demetrio si presentò da mio padre con aria triste e sconsolata. Mai e poi mai avrebbe esercitato quella professione. Per il suo animo sensibile, non gli era possibile vedere dalla mattina alla sera cani e gatti impauriti e sofferenti, nemmeno se il fine era quello di guarirli.
Papà scosse la testa. Non riusciva a capire perché impegnarsi tanto nello studio per poi non concretizzarlo in un lavoro conseguente. Provò a convincerlo ma non ci fu nulla da fare, Demetrio era tanto impressionabile ed emotivo quanto risoluto nelle sue decisioni.
La soluzione, come capitava spesso, arrivò da mia madre. Gli propose di lavorare al bancone del bar del ristorante. Demetrio accettò di buon grado, l’idea gli piaceva, tanto da diventare in pochi mesi un abile e apprezzato barista.
Anche il cibo emigra
La sua vera passione, però, era la cucina. Un’arte appresa da sua madre Rosa, che io chiamavo “la regina dei pomodori ripieni” per la bontà di questo piatto che preparava a meraviglia.
Il segreto stava nel ripieno, che al Sud non è una semplice miscela di ingredienti usata per imbottire un alimento, ma una vera e propria preparazione a sé stante. Per questi pomodori, Rosa utilizzava pan grattato, prezzemolo, basilico, con l’aggiunta di un formaggio dal sapore deciso, come il pecorino o la scamorza, rigorosamente affumicata. Ero un ragazzino, ma ricordo ancora oggi il gusto irresistibile di quei pomodori.
Demetrio, come tutti i migranti, portava con sé i ricordi dei sapori e dei profumi della sua giovinezza calabrese. Perché anche il cibo emigra insieme a chi, con il cuore addolorato ma colmo di aspettative, lascia la propria terra. Non è un caso che la popolarità della nostra cucina sia stata accelerata dalle migrazioni, da quegli italiani nelle cui enormi valigie vi era ampio spazio per le proprie consuetudini alimentari.
Nel secolo scorso, la cucina italiana è stata soprattutto “la cucina delle partenze”, verso un altrove rappresentato da Germania, Francia, Svizzera, Argentina, Brasile, Stati Uniti.
Lo straniamento del ritrovarsi in un luogo sconosciuto, il dover faticosamente imparare una nuova lingua, veniva stemperato con la pasta, il sugo, la polenta. Pietanze che contribuivano ad attenuare il timore del futuro, quando ancora non era possibile sapere se sarebbe stato meglio del passato che, nella maggior parte dei casi, era fatto di fame nei giorni feriali e di tavole allargate all’intera famiglia la domenica.
Un Natale multiculturale
Demetrio sapeva che gli stessi princìpi riguardavano tutte le tradizioni culinarie del mondo. E valevano per tutti gli uomini e le donne, di qualunque nazionalità, che avevano lasciato il proprio Paese.
Dalla sua inaugurazione negli anni Cinquanta, il nostro ristorante è sempre stato un crocevia esistenziale di eterogenea e variopinta umanità. E quale occasione migliore poteva esserci, se non il pranzo di Natale, per riunire attorno al tavolo di casa sua quanti lavoravano Da Mimmo e che provenivano da terre ben più lontane della sua amata Calabria?
Per questo, ogni anno, Demetrio organizzava un Natale multiculturale in cui le persone, spesso sole come lui, celebravano il 25 dicembre condividendo i loro piatti della festa. Un solo Natale – tunisino, polacco, senegalese, rumeno, ucraino – e una sola tavola che riuniva ogni etnia e ogni religione.
In quel giorno speciale, alle pietanze veniva aggiunto un ingrediente altrettanto speciale: quella componente irrazionale e magica che accomuna e consola.
Il rapporto tra cibo, vino e festa racconta la storia dell’uomo. Demetrio sapeva che spartire e scambiarsi il pane e il companatico era l’unica via per costruire una vera comunità. E non c’è comunità senza narrazione, in cui non possono mancare la tavola e i suoi miti.
Per conservare il ricordo di un piatto è necessario conoscere a fondo la sua preparazione. La relazione tra pietanza e reminiscenza trova concretezza nella pratica gastronomica, per questo la memoria va coltivata e mantenuta seguendo una liturgia fatta di gesti semplici ed essenziali, facili da riproporre.
Demetrio chiedeva lumi, si informava e approfondiva, per allestire al meglio il suo Natale e quello dei suoi compagni di lavoro e d’avventura. Consapevole che, in cucina, le tecniche e i procedimenti adottati per ogni ricetta sono la sintesi della cultura di un popolo, dei suoi viaggi, dei suoi saperi.
Una necessità dell’anima
Ogni Natale, in tarda mattinata, andavo a trovarlo per fargli gli auguri. Lo trovavo sempre sommerso da decine di pentole e padelle. Cucinava senza voltare lo sguardo verso di me tanto era indaffarato.
Purtroppo, Demetrio non c’è più. Da qualche tempo è tornato dove il suo nome ha tratto origine, alla Madre Terra, ma ricordo bene quell’ultimo Natale in cui lo vidi ai fornelli. Aveva lo stesso sguardo assorto di sempre, quello di chi non cucina per soddisfare un piacere personale o per mostrare la propria abilità, ma per una necessità dell’anima.
Mentre amalgamava il ripieno dei pomodori, mormorava qualcosa di incomprensibile. Non era una preghiera, nemmeno un canto: era un dialogo sommesso con le sue memorie. Riportava in vita sua madre Rosa, le pesanti e rudimentali stoviglie di quella cucina con le finestre sempre aperte. Ripensava alla terra brulla e assolata dove era cresciuto.
Quando i suoi ospiti iniziarono ad arrivare, uno alla volta, rimasi colpito da come ognuno di loro portasse con sé un odore differente: cannella, cumino, cipolla fritta, arancia candita. Nessuna di quelle fragranze apparteneva alla nostra tradizione. Eppure, in quella casa, ognuna di esse trovava il proprio posto senza scontrarsi con le altre. Era come assistere alla nascita di una nuova lingua, che non aveva dizionario, ma che tutti capivano.
Con i suoi commensali, Demetrio non faceva discorsi sul Natale, né sulla fratellanza o sulle migrazioni. Non ne aveva bisogno. Posava i piatti sul desco come si pone qualcosa di fragile e prezioso, mentre ciascuno dei presenti si sedeva a tavola con rispetto, consapevole del profondo significato di quel convivio.
Probabilmente il Natale è anche questo. Un uomo dal nome che sa di profezia, che impasta memorie e futuro per trasformare la solitudine in una tavola apparecchiata dove tornare a casa. Anche solo per il tempo di un pranzo.