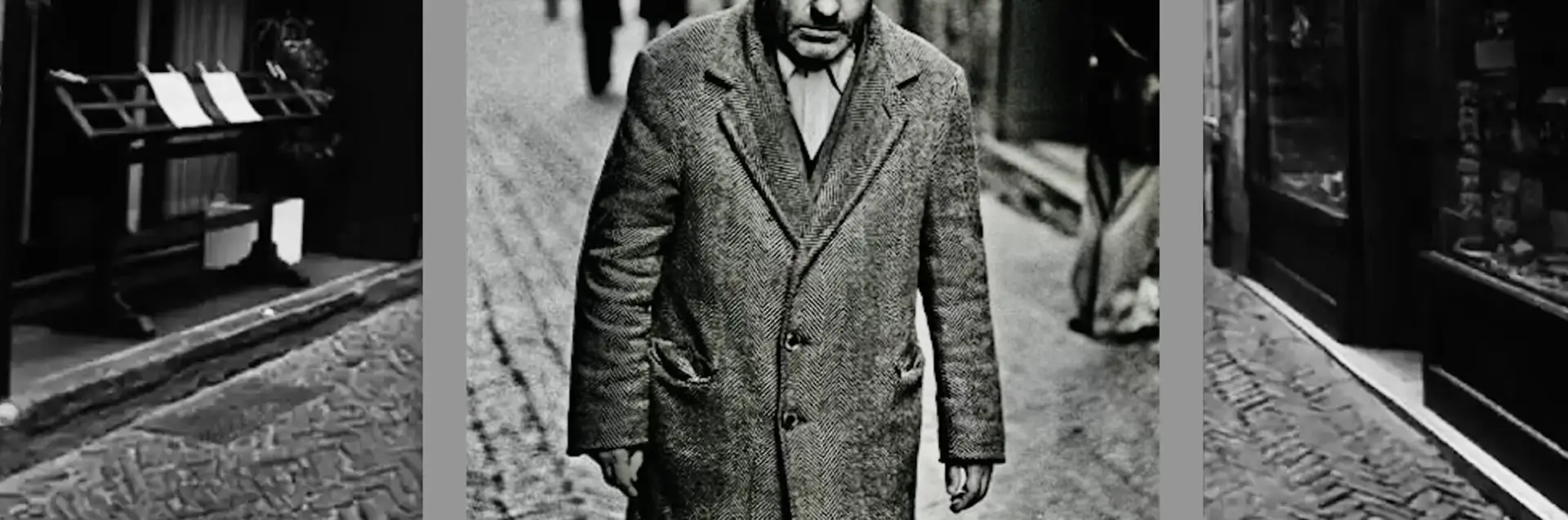- Nato in Città Alta
Un’estate fa
Tempo di lettura: 7 minuti
Al riparo dal sole cocente delle due e in attesa dell’espresso preparatomi da Doris – l’unica a conoscere la bevanda misteriosa con cui correggo il caffè – il più grande dei miei figli, tra una citazione di Kant e un’ingenua domanda sul Milan, mi ha chiesto: “C’è un’estate della tua vita che vorresti rivivere? La più importante, non per forza la più bella”.
Al momento, non ho saputo rispondere. È un quesito difficile, anche se, di certo, avrei scelto una delle estati che ho vissuto da ragazzo, perché solo durante l’adolescenza ogni esperienza diventa unica e indimenticabile.
Da metà giugno a metà settembre, il tempo pareva dilatarsi, complici l’alba precoce e il tramonto tardivo. Ero in vacanza e godevo anche di maggiore libertà: gli orari di uscita e di rientro a casa erano più blandi.
In quei mesi soggiogati all’ozio, al caldo e alla luce, rivolgevo il mio sguardo assetato a un mondo dove tutto era nuovo e da scoprire. Ero impaziente di diventare grande e mi apprestavo a succhiare il midollo della vita, per usare le parole del professor Keating nell’Attimo fuggente.
Erano giorni in cui bastava davvero un niente per passare dalla noia mortale alla gioia più sfrenata. Un incontro inaspettato mentre vagabondavi per i Colli, lo stupore per una canzone che non avevi mai sentito: in un attimo svoltavi dall’apatia all’estasi, con mille sogni e progetti da realizzare.
Densa di avvenimenti, non tutti all’insegna della spensieratezza, l’estate del 1980 fu un’estate davvero speciale. Frequentavo le seconda liceo e fui promosso a giugno grazie a un fenomenale recupero in matematica nel mese di maggio. Neanche Marino Basso sul traguardo del Mondiale di ciclismo del 1972, quando all’ultimo metro superò di mezza ruota Franco Bitossi, fu capace di prodursi in uno sprint di tale livello.
Ed ecco che potevo godermi ogni istante di quell’estate e dedicarmi a uno dei miei passatempi preferiti: girare in sella alla mia Vespa 50 Special, terza serie, senza pormi una destinazione.
Fu proprio in questo mio bighellonare in giro per Città Alta che, uno dei primi giorni di vacanza, incontrai un amico che non vedevo da un po’. Uno di quelli con cui non hai un legame particolarmente stretto ma che ti è simpatico perché brillante e traboccante di iniziative. Mi confidò che, da qualche settimana, sul colle di San Vigilio c’era la sede di una radio. Erano suoi amici e mi propose di fare un salto lì.
Dai Genesis alla Bertè.
Nel tragitto pensai a una canzone di Eugenio Finardi uscita qualche anno prima e pubblicata come lato B del singolo “Musica ribelle”. Nonostante il titolo poco fantasioso – “La radio” – era proprio una bella canzone. In poco tempo era diventata l’inno delle tantissime radio libere che si stavano diffondendo rapidamente in tutta Italia.
Tempo un quarto d’ora ed eravamo lì, davanti a una porticina anonima, quasi angusta.
Entrammo in punta di piedi, come in una cattedrale. Se avessi avuto in testa un cappello probabilmente me lo sarei tolto per rispetto.
Ci ritrovammo in una grande stanza le cui pareti erano allestite con scaffali stipati di ellepì. I ripiani erano organizzati per autori e generi musicali e ce n’era per tutti i gusti: pop e rock, new wave e “prog”, musica inglese, americana e italiana, impegnata e di consumo, e anche un po’ di jazz.
Da quello studio, cuffie enormi sulle orecchie, due ragazzi poco più grandi di noi si alternavano nel lanciare nell’etere i loro brani preferiti. Invidiai un poco la loro competenza e la passione che intrideva ogni loro parola nel presentare la canzone pronta per essere messa in onda.
Trasmettevano i cantautori italiani che amavo di più. De Gregori, Guccini, De André, Dalla, Bennato, il primo Battiato. Davano spazio anche ai cantanti definiti più commerciali, come Gianni Bella o Umberto Tozzi. A me piacevano molto anche quelli, specie in estate, quando il disimpegno e la leggerezza sono sovrani. Una predilezione di cui mi vergognavo un po’, e che tenevo ben celata ad alcuni dei miei amici, quelli più impegnati politicamente, per mettermi al riparo da critiche e prese in giro.
Alle atmosfere cupe e crepuscolari di “A Forest” dei Cure poteva benissimo fare seguito “Nuntereggae più” di Rino Gaetano, con la sua ironia acida e irriverente. Veniva mandata in onda musica di ogni genere, senza preclusioni. Bob Dylan e subito dopo Adriano Pappalardo, i Genesis e a seguire la Bertè. Era una cosa che adoravo, la trovavo elettrizzante ed estremamente democratica.
E così mi capitava di ascoltare brani che forse non avrei scelto ma che alla fine mi piacevano, Franco Simone o Donatella Rettore, con le loro “hit” da cantare a squarciagola andando in moto o facendo la doccia. Canzoni che ancora oggi, ogni tanto, mi tornano alla mente e di cui ricordo i testi, parola per parola.
E guardo il mondo da un oblò.
In compagnia del mio amico ritrovato, iniziai a trascorrere interi pomeriggi in quella radio libera.
Studiavo nei dettagli le copertine di tutti quegli ellepì, leggendo le note a margine e scoprendo i nomi di tutti i musicisti che avevano lavorato al disco, il nome del produttore e, infine, le dediche, alla moglie, alla mamma, all’amante o a chissà chi.
In quell’estate del 1980, la canzone più in voga era “‘Luna” di Gianni Togni. “E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po’. Passo le notti a camminare, dentro un metrò’”. Era perfetta da cantare o fischiettare in sella alla mia moto.
Il vento caldo e umido di quei mesi estivi mi donò anche le prime irreprimibili pulsioni amorose, ancora un po’ vaghe e non ben indirizzate. Secondo l’umore canticchiavo “Rimmel” di De Gregori o “Ti Amo” di Umberto Tozzi.
Due canzoni scritte a metà anni Settanta e decisamente agli antipodi. “E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure” e “Apri la porta a un guerriero di carta igienica” avevano davvero poco da spartire. Eppure, nella mia mente, si abbracciavano e si confondevano. Il dolore e la gioia, il sacro e il profano. Perché profondo e superficiale, in fondo, possono convivere senza conflitti, anche se poi da adulto spesso te lo dimentichi.
L’adolescenza è una terra di mezzo.
Nell’adolescenza, l’innocenza irrimediabilmente perduta dell’infanzia lascia spazio a un cuore che batte all’impazzata per aver sfiorato la mano di una ragazza o alla disperazione ripensando a quel gol annullato a Chiarugi contro la Lazio nel lontano 1973.
Si prendono le misure con le emozioni, fino a quel momento confuse e indefinite. Si imparano a gestire anche lo sconcerto e lo smarrimento degli eventi più tristi e, in quell’estate per me così entusiasmante, nel nostro Paese successero cose terribili. L’esplosione in volo di un aereo che viaggiava verso Ustica. Ottantuno morti, agnelli sacrificali di un’assurda battaglia aerea tra velivoli nemici. E l’attentato terroristico alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto, anche qui con oltre ottanta vittime innocenti.
Pochi giorni dopo la strage, salii sul treno per andare in Calabria e trascorrere un paio di settimane con i parenti di papà. Non dimenticherò mai la visione dell’orologio della stazione bolognese fermo all’ora dell’attentato.
Quelle lancette immobili che cristallizzavano la follia di quell’atto così vile e ingiusto fecero germogliare in me il desiderio di non essere un semplice osservatore della vita. Capii che dovevo mettermi in gioco senza paura, impegnandomi anche per gli altri. La vita non era solo cantare “Stella stai” di Umberto Tozzi scendendo col sorriso stampato in faccia da San Vigilio, ma era tutto ciò che mi accadeva intorno, di bello e di brutto. Servivano un po’ di sogni per colorarla e una buona dose di coraggio per affrontarla.
Stai, stella stai, su di me, questa notte come se, fosse lei, fosse Dio, fosse quello che ero io.
E forse non fu un caso se proprio quell’estate, a pochi giorni dal rientro a scuola, vidi per la prima volta “Il sorpasso” di Dino Risi. Un capolavoro del cinema italiano, girato nel 1962, che descrive con disincanto l’allegria imbevuta d’amarezza e solitudine delle estati nostrane. Commedia e tragedia restano in bilico per tutto il film grazie una sceneggiatura che rasenta la perfezione assoluta e alle magistrali interpretazioni di Gassman e Trintignan. Un po’ Bruno, un po’ Roberto – i due protagonisti del film – mi rividi in entrambi.
Come in un disco in vinile, la vita ha un lato A e un lato B e in quell’estate del 1980 – non la più bella ma decisamente significativa e propedeutica alle mie scelte future – li ho ascoltati tutti e due. E a mio figlio, oggi, direi di fare la stessa cosa. Di accettare con la mente aperta i due lati della vita, che è fatta di leggerezza e responsabilità. Ma soprattutto gli direi di ascoltare sempre la radio.