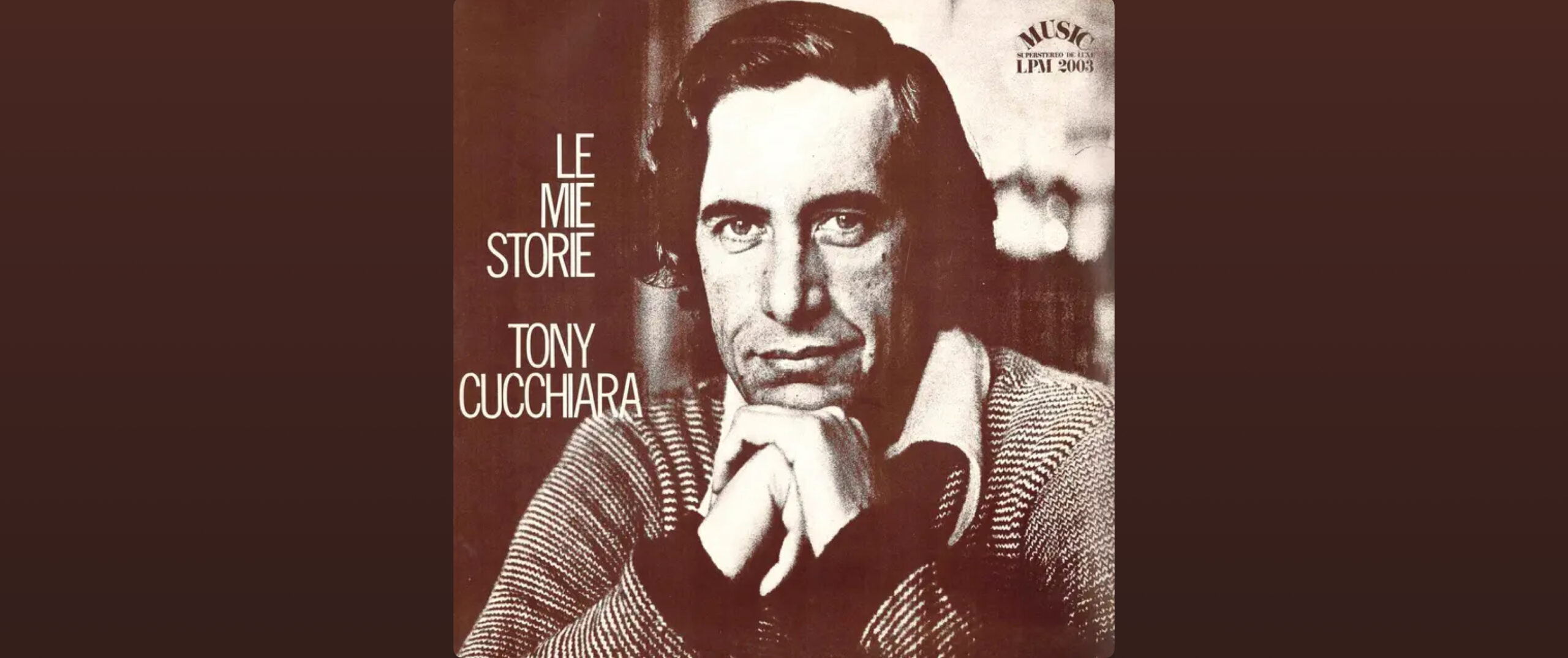- Due calci al pallone
Totaalvoetbal: il calcio totale
Tempo di lettura: 7 minuti
E Vincent vide il granoturco
E Einstein il numero
E Zeppelin lo Zeppelin
E Johan vide il pallone
(Toon Hermans)
Ci si può innamorare di una squadra di calcio per i colori della sua divisa. Come l’arancione bordato di nero dell’Olanda ai Mondiali del 74. Una tinta che non avevo mai visto sulla maglietta di un club o di una nazionale. È vero, ci sono gli inglesi del Blackpool, oggi in terza serie, così come il Volendam, che ora gioca nella serie B olandese, ma tutto questo l’ho scoperto più tardi, non ricordo se sulle pagine del Guerin Sportivo o consultando il catalogo delle squadre di Subbuteo.
Il fascino del colore che dal Cinquecento rappresenta la famiglia reale olandese era irresistibile, certo, ma fu il loro modo di giocare a rubarmi il cuore. Nonostante i miei nove anni appena compiuti, percepivo qualcosa di epocale e di grandioso, una rivoluzione che andava oltre il pallone.
Si trattava del calcio totale, il “Totaalvoetbal” come lo chiamarono gli olandesi, che si basava su una nuova teoria di flessibilità spaziale.
Come ha scritto David Winner nel suo ispiratissimo “Brilliant Orange”: “Quella modernissima concezione del football fondata sullo sfruttamento e il controllo dello spazio di gioco proseguiva, in nuovi modi, la secolare battaglia degli olandesi per strappare terre al mare. La geometrica perfezione dei quadri di Mondrian ritornava, in diversa forma, nei Tulipani su un prato erboso”.
D’altra parte, già nell’XI secolo San Bernardo di Chiaravalle – caso raro di santo venerato da cattolici, anglicani e luterani – affermò: “Cos’è Dio? Dio è lunghezza, altezza, larghezza, profondità”.
Modernità liquida e fisica quantistica.
In Olanda, erano stati capaci di concepire e realizzare i “polder” – aree di terra sottratte al mare, prosciugate e protette da dighe – in grado, nei fatti, di aumentare le dimensioni fisiche del Paese. Allo stesso modo, gli undici protagonisti in campo rendevano flessibili le misure del terreno di gioco, a seconda che fossero in possesso della palla o no.
Attacco incessante, pressing e compressione dello spazio per ridurre le dimensioni del campo quando si deve prendere palla; estensione del gioco ed espansione del campo in fase di possesso.
Erano i principi fondamentali che permisero all’Ajax di Amsterdam, nei primi anni Settanta, di vincere tutto ciò che c’era da vincere demolendo ogni avversario. Potendo contare sulla maggior parte di quegli stessi interpreti, sia in campo sia in panchina, quei medesimi principi di gioco vennero riproposti dalla nazionale olandese al mondiale tedesco.
Su quel rettangolo verde, cento metri per sessantacinque o giù di lì, ogni ruolo era interscambiabile. Si invertivano le posizioni in maniera spontanea, dove la fase d’attacco era una sorta di anticipazione della modernità liquida alla Zygmunt Bauman, contraddistinta dalla flessibilità e dal cambiamento continuo, mentre per la fase difensiva potremmo scomodare la fisica quantistica. Come potevo non esserne rapito?
Vivere al di sotto del livello del mare.
Quella destabilizzante nuova filosofia di gioco non presumeva più che un singolo giocatore si rendesse protagonista di corse da sessanta metri, ma che ognuno corresse non più di una decina di metri partendo dalla posizione in cui si trovava.
Per comprendere queste idee all’avanguardia è necessario identificarsi nella temerarietà di chi, da sempre, vive al di sotto del livello del mare. Una condizione di assoluta precarietà, dove la tua esistenza può dipendere dall’intraprendenza di un ragazzino capace di bloccare con un dito una falla nella grande diga a protezione della città di Harlem, evitando che quest’ultima venisse spazzata via dalle onde impetuose del mare del Nord. Ce lo narra un’antica leggenda olandese e vogliamo crederci.
Mi innamorai degli “Oranje” già dalla prima partita, in cui vinsero 2-0 contro l’Uruguay. Restai a bocca aperta nell’osservare le traiettorie delle loro corse senza palla, intricate e imprevedibili.
Erano lenti e veloci allo stesso tempo. Concentrati e rilassati, strutturati e destrutturati. Tutto ciò, ai miei occhi, aveva un qualcosa di ipnotico e affascinante.
In quella fitta rete di movimenti, passaggi e lanci inaspettati convivevano il desiderio di andare sulla luna e quello di vivere sotto il mare. Era un nuovo modo di intendere il calcio dove potevi cogliere il passaggio dal figurativo all’astrattismo, come su una tela.
I giocatori olandesi davano l’impressione di battersi per un’ideale, per un modello culturale. Ad ogni intervista, comunicavano la loro gioiosa determinazione. Si esprimevano correttamente e in più lingue. Li trovavo irresistibili e seducenti. Tutti quanti.
Non tutte le fiabe finiscono come vorremmo. Quella squadra meravigliosa dominò il Mondiale ma perse la finale. Per la seconda volta in poco più di un anno, dopo la fatal Verona milanista, il mio cuore andò in frantumi. Se poi ci aggiungo che l’8 maggio di quello stesso anno il Milan venne sconfitto nella finale della Coppa delle Coppe dai tedeschi oltre cortina del Magdeburgo – lasquadra di Sparwasser e Pommerenke – la mia iniziazione ai dolori e ai tormenti della vita fu completa. Lo stadio era il De Kuip di Rotterdam, la tana del Feyenoord, e pure l’arbitro era olandese. Singolari incroci e coincidenze con la terra dei tulipani.
Conservatori, riformisti e radicali.
Il giornalista Lorenzo Fabiano sintetizza con acume ciò che rappresentò il Mondiale del 74: “Sono i giorni che per l’universo calcistico segnano il passaggio al futuro, la rivoluzione industriale. Un confronto tra conservatori, riformisti e radicali. I primi, tra cui noi italiani, fedeli all’Ancien Régime, pensano che il talento sia sufficiente per essere i migliori, e che a calcio si possa ancora giocare passeggiando sull’erba. I riformisti, tra cui i tedeschi, irrobustiscono la qualità con organizzazione e forza atletica. I forieri della rivoluzione, gli olandesi belli e impossibili, rimarranno a mani vuote, ma passeranno alla storia per aver messo la firma sul big-bang che cambierà per sempre il volto al calcio. Da quell’estate del 1974, nulla sarà più come prima”.
Ogni momento cruciale della storia, pure quella calcistica, ha i suoi eroi. Il cavaliere senza macchia di quella squadra era Johan Cruijff, un orfano di padre cresciuto dalla madre che di mestiere faceva le pulizie nello stadio dell’Ajax. Fu il primo calciatore a intuire la propria natura illuminata di artista, tanto da dichiarare: “In un certo senso, probabilmente sono immortale”.
Si esprimeva per frasi concise e asciutte, come: “Ogni svantaggio ha il suo vantaggio” o “Il calcio è semplice, ma è difficile giocare semplice”. Anche quello ritraeva l’inizio di una nuova era nella comunicazione dell’ars pedatoria.
Fino ad allora, l’Olanda era considerata bella ma triste. Lo scrittore Albert Camus trascorse ad Amsterdam alcuni mesi in cerca di ispirazione per un suo nuovo romanzo. Lo voleva ambientare proprio lì, tra i canali della capitale olandese, che descrisse in questo modo: “Qui, da secoli, fumatori di pipa contemplano la medesima pioggia che cade sul medesimo canale”.
Negli anni Sessanta, la città sbocciò improvvisamente grazie a un movimento controculturale – il Provo – che auspicava la nascita di una collettività in cui creatività e immaginazione, proiettate in ogni ambito e direzione, sarebbero stati i valori portanti di una nuova società. L’aggressività avrebbe lasciato il posto all’allegria, la severità alla leggerezza.
Quel Paese si era trasformato completamente, tanto che la “protesta bianca” di John Lennon e Yoko Ono contro gli orrori della guerra in Vietnam si svolse all’hotel Hilton di Amsterdam, nel 1969, durante la loro luna di miele. Fu un “Bed-In for Peace”, in cui la coppia trascorse un’intera settimana nel letto della loro suite invitando i media a parlare di pace.
Un indovinello avvolto in un mistero all’interno di un enigma.
Roel van Duijn uno dei leader storici del Provo, asserì: “Tutti hanno bisogno di giocare a calcio”.
In quegli anni, il football esprimeva compiutamente la mentalità di un popolo le cui radici, cosìcome la visione del futuro, traevano linfa vitale dall’architettura, dalla filosofia, dalla scienza, dall’arte. In sintesi, dalla bellezza.
Da allora, su un terreno di gioco, verde o brullo che sia, gli olandesi preferiscono affrontare ogni avversario con la bellezza e con l’intelletto piuttosto che con la forza e con l’astuzia.
Pur giocando il calcio migliore – almeno nel 74 e forse anche nel 78 – mi chiedo come sia possibile che l’Olanda abbia perso tutte e tre le finali mondiali che ha disputato. Mi piange il cuore, ma per citare Winston Churchill: “È un indovinello avvolto in un mistero all’interno di un enigma”.