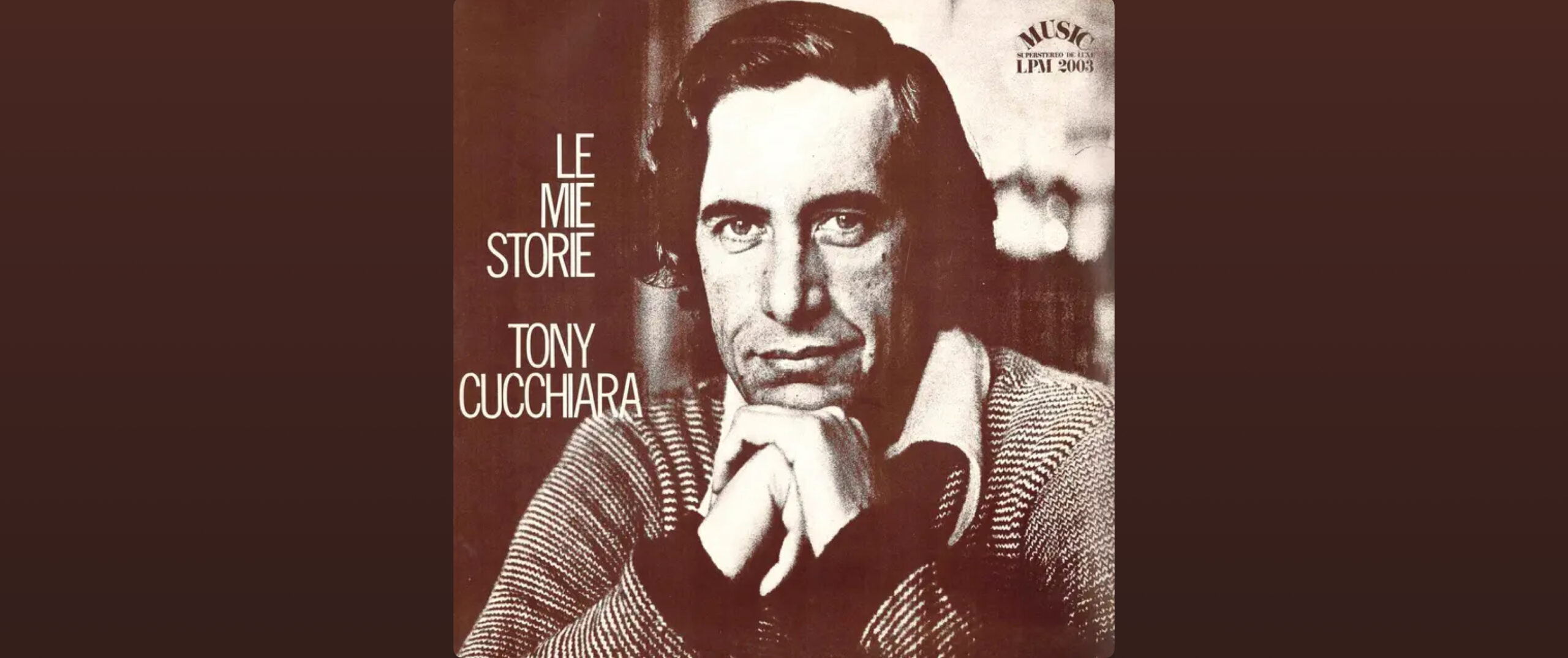- Due calci al pallone
Una vita per il fùbal
Illustrazione di Adalberto Bortolotti
Tempo di lettura: 6 minuti e mezzo
Ognuno di noi ha un luogo del cuore. È sufficiente udirne il nome per evocare emozioni ad alta intensità, che ci riportano in un attimo un momento indimenticabile di crescita e di scoperta.
Per me, questo luogo – un po’ mitico e un po’ magico – è il campo da calcio della Fara. Ai miei occhi di bambino, e poi di adolescente, era quanto di più simile a San Siro o al Maracanà.
Su quel terreno di gioco un po’ sghembo e irregolare – che fino ai primi anni Trenta era solo un’enorme buca chiamata “ol fupù” dagli abitanti di Città Alta – potevi sognare di essere un calciatore. Proprio come quelli delle figurine Panini che conservavo gelosamente in cartella, nel mio astuccio, in compagnia di gomme e matite. O quelli che vedevo in tivù, ogni domenica alle 17 e 45, a “Novantesimo minuto”, condotto da Maurizio Barendson e Paolo Valenti con una sobrietà che oggi troveremmo irreale .
Sempre la domenica, ma a mezza mattina, scendevo di corsa dalla Corsarola per vedere le sfide dei grandi. Due squadre schierate in undici contro undici. Non come in cortile o all’oratorio, dove giocavamo in sei contro cinque perché in una squadra ce n’era uno più grande, e dove valeva tutto, pure le sponde contro i muri.
Indossavano magliette vere, bellissime, con i numeri sulla schiena. E c’era perfino l’arbitro, serio e impettito nella sua divisa nera col colletto bianco, giudice unico e supremo di quanto avveniva in campo. I giocatori duellavano con grande animosità su quel prato punteggiato di buche, in cui si alzavano nuvole di polvere se non pioveva da qualche giorno. Volevo a tutti i costi essere uno di loro.
Scrutavo gli spettatori rapiti dallo svolgersi delle azioni in campo, immuni al freddo e alla pioggia. Gli occhi sbarrati, le sigarette fumate con rabbia e buttate via a metà. Ascoltavo le loro urla di incitamento o disapprovazione, i commenti tecnici espressi con l’autorevolezza di chi ha tanto da insegnare a quell’incompetente dell’allenatore e a quell’incapace dell’arbitro.
Ragioniere di mestiere e allenatore per passione.
Il solo ritrovarmi alla Fara, per me, era fonte di gioia. Ma non ci sono luoghi del cuore se non ci sono persone care e degne di essere ricordate. Come il Gianni Morosini – rigorosamente con l’articolo, come si usa da queste parti – ragioniere di mestiere e allenatore per passione. Sempre con la sua tuta d’ordinanza, con tanto di sponsorizzazione sul petto di una sconosciuta impresa locale di idraulica, l’immancabile basco blu e gli stivali pure d’estate.
Il Gianni non era solo un allenatore, gonfiava i palloni, segnava le linee del campo con il gesso spingendo una carriola con il buco sotto, scriveva le distinte per le partite, e, quando si andava in trasferta, caricava buona parte della squadra nella sua sgangherata, ma sempre affidabile, Fiat 128 verde bandiera con impianto a gas.
Le linee di gesso seguivano le irregolarità di un rettangolo di gioco dove l’erba lasciava ampio spazio alla terra e alle pietre. Il Gianni era un ragioniere, non un geometra, e faceva il possibile. E poi a me sembrava già un sogno giocare in un campo dove erano disegnate addirittura la lunetta e l’area di porta.
Alcuni credono che il calcio sia una questione di vita o di morte. Non sono d’accordo. Il calcio è molto, molto di più.
Compiuti gli undici anni, finalmente, potevo far parte di una squadra di calcio. Trascorsero meno di ventiquattr’ore dall’aver soffiato sulle candeline della torta del mio compleanno, che mio padre mi accompagnò ad acquistare le mie prime scarpe da calcio, provviste di tacchetti in ferro: un paio di Rutilius nuove fiammanti.
Una decina di allenamenti ed ecco il mio esordio a centrocampo in una squadra vera: la Vecchia Bergamo. È stato un disastro. Non riuscivo quasi mai a prender la palla, tanto meno a farmela passare. Il campo mi sembrava infinito, troppo grande rispetto al giardino del ristorante.
Il Gianni, da bordo campo, non ci andava per il sottile con i rimproveri e gli incitamenti. In mano aveva la bandierina da guardalinee che doveva servirgli per segnalare all’arbitro quando la palla usciva, ma l’uso reale che faceva di quell’attrezzo era per indicare a noi, agitandosi come un ossesso, ciò che dovevamo fare in campo.
All’inizio, le sue urla mi intimorivano ma capii presto che quella era una partita vera. In gioco, oltre al risultato, c’era ben altro. Come disse Bill Shankly, leggendario allenatore del Liverpool dal 1959 al 1974: “Alcuni credono che il calcio sia una questione di vita o di morte. Non sono d’accordo. Il calcio è molto, molto di più”.
In quei primi novanta minuti più recupero, avvertii tutto il peso di quel momento iniziatico: era il passaggio dall’effimero al concreto, da un desiderio che si realizzava alla cruda oggettività di una vittoria o di una sconfitta. Alla Fara si diventava adulti sudando e correndo dietro a un pallone.
Ricordo le parole del mio amato Nils Liedholm. “Ci sono giocatori che vanno verso il pallone. Quasi tutti. E ci sono palloni che vanno dai giocatori. Succede solo ai più bravi”. Io me la cavavo discretamente, ma ero nella media. Compresi che, se volevo quella benedetta sfera di cuoio dovevo andare a prendermela, mettendo da parte ogni titubanza e confinando in un angolo la timidezza.
E adesso come si fa?
Alla Fara, poi, avevamo una complicazione: non c’era la recinzione. Quando la palla veniva calciata con troppa forza, o il tiro era sbilenco, andava a finire nei campi appena sotto le Mura.
“E adesso come si fa?” diceva il Gianni, sapendo benissimo che non mancava mai un volenteroso disposto a farsi una bella corsa in discesa per andare a recuperare il pallone disperso nell’erba alta. Interruzioni che potevano durare dieci minuti o un quarto d’ora, e più d’una a partita. Ma solo in questo modo, quelle sfide all’ultimo placcaggio potevano concludersi con il triplice fischio a sancire la fine della partita.
L’unicità del campo della Fara stava nelle antiche Mura veneziane come linea laterale, i passanti obbligati al ruolo di raccattapalle e, a far da splendida cornice, l’imponente chiesa sconsacrata di Sant’Agostino. “In eminenza vedesi sospesa / la chiesa d’un sol vaso ornata, e grande / con alta faccia a gotico distesa”. Così, nel Settecento la descrive Giovanni Battista Angelini.
Vincendo il timore reverenziale che avevamo nei suoi confronti, noi ragazzi provammo a dire al Gianni che i campi dei paesi dove andavamo in trasferta erano tutti più belli del nostro. L’erba tagliata come si deve, le panchine coperte e le tribune dedicate agli spettatori. Lui ci squadrò come mocciosi ingrati e viziati. Dopo almeno un minuto di silenzio assoluto, ci rispose: “Guardate in alto e alle vostre spalle, chi altri può vantarsi di avere la Rocca a proteggerci e una chiesa con mille anni di storia a guardarci?”
Lì per lì nessuno capì cosa c’entrassero quei monumenti con una partita di calcio. José Mourinho ha affermato “Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio”. Ed è vero. Il calcio è bellezza, storia e cultura. E poi, come diceva il Gianni: “il vino lo si fa con l’uva che si ha”.
Non era più la stessa cosa.
Mentre sulle nostre guance spuntavano i primi peli della barba, in sodalizio inevitabile con qualche fastidioso brufolo, trascorsero anni spensierati. Un bel giorno, però, il Gianni ci comunicò che dalla stagione seguente non ci avrebbe più allenato. Voleva dedicarsi alla squadra femminile di pallavolo di Città Alta. Il suo sogno era quello di creare una vera polisportiva e, secondo lui, quello era il primo passo da compiere.
Rimanemmo straniti e, all’istante, orfani di quest’uomo che ci apostrofava abitualmente come “randagi” ma che, a modo suo, ci voleva bene. Continuammo con gli allenamenti e le partite, anche con buoni risultati, ma senza il Gianni Morosini non era più la stessa cosa.
Oggi il prato della Fara è bello come non lo è mai stato. Non ci sono più le linee tracciate con il gesso, né storte né dritte, e non ho mai visto quell’erba tanto verde e rigogliosa. Ma lì non si più gioca a pallone. Un po’ perché il campo non è omologabile e di bambini che abitano in Città Alta ce ne sono davvero pochi ma, soprattutto, perché non c’è più il Gianni.